Aspettando che Nedo torni, con la riedizione de “Il mio nome è Nedo Ludi” e la pubblicazione di “Nedo Ludi. Il ritorno”, ripubblico uno dei capitoli del libro pubblicato nel 2006 da Baldini Castoldi Dalai. Inserisco anche i video dei brani che in alcuni passaggi ricostruiscono l’atmosfera narrata. Buona lettura.
Dopo la partita contro il Napoli, Nedo si trovò retrocesso a quarto difensore centrale dell’Empoli. Bonazzi e Natali erano ormai i titolari designati e Vascotto la loro prima riserva. Nel giro di una settimana era precipitato dalla condizione di Generale Ludi all’essere il nuovo Vrenna, riserva della riserva. Aveva ballato una danza superba e dissipatrice sul ciglio dell’abisso, convinto che oltre quello fosse il volo. Sentì il tonfo della caduta soltanto quando alla quarta o quinta tacchettata incise un cratere sul legno tarlato della panca, nel buio umido dello spogliatoio. Poi sedette e rimase lì a rimuginare nell’oscurità. Era ancora lì quando la squadra e l’allenatore rientrarono per l’intervallo. Favrin fu l’unico che s’accorse della sua presenza perché accendendo la luce saltò su dallo spavento al vedere quella figura immobile come una statua.
Tutti gli sfilarono accanto e bivaccarono per un quarto d’ora nello stanzone a svolgere le ordinarie attività da intervallo. Come se lui non ci fosse. Ascoltarono le indicazioni di Bersani, parlarono fra di loro, bestemmiarono contro quel diluvio che ormai nemmeno ticchettava più sui vetri ma li solcava con flusso compatto, e sostituirono le maglie fradice. Poi uscirono e girarono l’interruttore della luce – lo fece Carrieri, che ancora non riusciva a capire cosa ci facesse lì, a Empoli e in A.
Nedo si trovò di nuovo sprofondato nel buio, e dovettero trascorrere altri cinque minuti prima che si togliesse di dosso l’abbigliamento da calcio. Passò un tempo imprecisato sotto la doccia senza insaponarsi. Quindi si rivestì che era circa la mezzora del secondo tempo e il rumore di sottofondo della partita era un brusio remoto, impossibile da decifrare. Seguì gli ultimi cinque minuti di partita dal fondo del corridoio, osservando uno spicchio di campo fra le due panchine in cui saettavano maglie azzurre e bianche, e che talvolta veniva ostruito dal guardalinee. Non gli fu necessario attendere il fischio finale per capire che il suo errore avesse provocato l’unico gol della partita, quello che condannò l’Empoli alla seconda sconfitta casalinga del campionato.
Avrebbe voluto tornarsene subito a casa. Lo trattenne l’orgoglio, che gli consigliò di non dare l’impressione stesse fuggendo via dal giorno e dal luogo della sua disfatta. E dopo lo trattenne il bisogno d’evitare il pubblico che sfollava dal Castellani, al quale non voleva mescolarsi per fare i 50 metri fino a casa. E poi ancora lo trattenne quella sensazione a metà tra rifugio e castigo che gl’infondeva lo stare dentro la stanza del magazziniere.
Rimase lì mentre le due squadre rientrarono negli spogliatoi. Bersani gli passò di fronte e parve guardargli attraverso. Come Nedo non esistesse, ma non esistesse davvero. Non era un far finta di non vederlo, ma un eliminarlo come specie visibile. Lo aveva trattato allo stesso modo durante tutta la settimana, e Nedo ne aveva ricavato alimento per il suo orgoglio guerriero. In quel momento capì che tanta indifferenza non era un buon affare, e meglio avrebbe fatto a non sottovalutarla. Arrivò poi l’ondata dei giornalisti. Qualcuno provò a intervistarlo. Nedo si limitò a scuotere il capo, poi s’allontanò nella stanza di Rolando Balli, il magazziniere. Che guardandolo negli occhi gli fece cenno di entrare senza dire una parola. In quella stanza vide passare il direttore sportivo Berti, il segretario Guasti, il presidente Magno. Poi arrivò Assirelli con due bicchierini di caffè appena zuccherato, che sorseggiarono in silenzio dandosi le spalle. Si fecero le sei e mezza, quando il custode del Castellani, Luigi Callipò, anche lui senza dirgli una parola gli fece cenno di dover proprio chiudere. Aveva già atteso abbastanza che Nedo si decidesse a andare via.
Il silenzio da cui fu inghiottito subito dopo la sostituzione rimase intatto per tutta la settimana successiva. Il lunedì sera entrò in casa dei genitori per la cena senza dire una parola, e senza dire una parola mangiò con loro e andò via salutandoli con un cenno muto. Anche loro dovevano avere i loro pensieri, che non riguardavano le cose calcistiche di Nedo. Forse nemmeno sapevano che il giorno prima ci fosse campionato. In silenzio, Nedo si allenò per tutta la settimana sentendosi isolato in mezzo al gruppo, come se un diaframma invisibile l’avesse contornato. Qualcuno fra i compagni gli rivolse delle parole di maniera, e tutti evitarono rigorosamente ogni riferimento all’errore che era costato la sconfitta nella partita contro il Napoli. Volevano evitargli ulteriore disagio, e invece il non detto aumentava il peso di una colpa sorda.
S’allenò con lo scrupolo di sempre in vista della partita contro il Milan che sapeva di non dover giocare. Arrivava Sacchi, con la sua squadra che guidava la rivoluzione culturale del calcio italiano, e passava da una delle province già conquistate alla causa del Progresso Calcistico. Bersani si sforzò di non darlo a vedere, ma l’attesa del confronto col maestro lo rendeva ansioso come un ragazzino. Durante la stagione precedente era stato qualche volta gli allenamenti a Milanello e non perdeva occasione di citare quei pomeriggi ogni volta che si trattava di motivare i giocatori empolesi. Come se sgobbare in allenamento fosse meno alienante a seconda dei princìpi filosofici e dei maestri loro propugnatori.
Era comunque un Milan molto cambiato da quello che Bersani e il resto d’Italia avevano visto fino alla conclusione della stagione precedente. Durante le prime due annate sotto la guida di Sacchi, la squadra rossonera aveva davvero fatto vedere qualcosa di nuovo, giocando un calcio che destava meraviglia per organizzazione e vincendo uno scudetto e una Coppa dei Campioni. Quella terza stagione, invece, era iniziata in modo stentato. In campionato i rossoneri avevano già perso 4 partite su 10, e raccolto soltanto 10 punti accumulandone 6 di distacco dal Napoli. Mercoledì 1 novembre, 4 giorni prima di scendere in campo a Empoli, avevano giocato il ritorno degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni al Bernabeu contro il Real Madrid. Riuscirono a superare il turno, ma proprio il confronto col modo in cui pochi mesi prima i rossoneri avevano strapazzato i campioni di Spagna dimostrò quanto fossero cambiate le cose. In aprile il Milan pareggiò a Madrid mettendo in soggezione il Real come mai alla squadra spagnola era successo in casa sua; e nella gara di ritorno la seppellì con un umiliante 5-0. In ottobre-novembre fu già un’altra storia. Nella partita d’andata, a San Siro, il Milan vinse con un rapido uno-due nel primo quarto d’ora. Il 2-0 giunse con un rigore di Van Basten concesso per un fallo sullo stesso attaccante olandese commesso fuori area dal portiere Buyo. La partita di ritorno fu vinta dal Real Madrid soltanto per 1-0, con un gol di Butragueno al 45’. Il secondo tempo fu un assedio degli spagnoli cui il Milan contrappose un catenaccio omerico. Avesse giocato così l’Inter di Trapattoni sarebbe stata crocifissa dalla stampa, pensò Nedo. Invece giornali e tv parlarono di resistenza eroica dei rossoneri, che fecero un ricorso massiccio alla tattica del fuorigioco. Gli attaccanti del Real vi incapparono più di 20 volte, mentre la loro frustrazione si trasformava in esasperazione per quell’avversario che s’arroccava e eludeva ogni confronto, giocando a non giocare. Ma per Sacchi il fuorigioco era una tattica d’attacco, il frutto di un’organizzazione scientifica del lavoro di squadra.
A eccezione dei casi in cui giocava la Juventus – ciò che gli derivava dalla fede viola – mai Nedo tifò così accesamente contro una squadra italiana impegnata in una partita di coppa. Avvertì sulla pelle la stessa frustrazione dei giocatori in tenuta bianca e del pubblico del Real, e quando uno degli ultimi assalti condotti dalla squadra spagnola venne fermato dall’ennesimo fuorigioco tirò un cazzotto alla scatola del televisore, che per qualche secondo venne attraversato da rumorose scariche colorate ma poi si riebbe. Intorno al 70’ Pippo pensò saggiamente di defilarsi dal salotto rifugiandosi in cucina, per non trovarsi a tiro di quella furia. Al fischio finale Nedo spense il televisore senza stare a ascoltare oltre quei commenti idioti che per tutta la partita avevano deformato la realtà delle cose. Trovava squallido il modo in cui il Milan s’era qualificato, giocando una partita difensiva come mai l’Empoli s’era azzardato a fare a San Siro o al Comunale di Torino. E sapeva che nessuno, sui giornali dell’indomani, avrebbe detto che il passaggio ai quarti di finale fosse dipeso dal rigore inesistente dell’andata. In compenso, quando in aprile al Bernabeu l’arbitro non vide un gol di Gullit la cui mancata concessione fu ininfluente ai fini della qualificazione, tv e giornali ne parlarono per mesi; mostrando immagini e foto di quello e altri episodi analoghi che non impedirono ai rossoneri di conquistare la prima Coppa dei Campioni dell’éra-Berlusconi.
Quella sera di mercoledì fu l’unico momento della settimana in cui Nedo ritrovò la voce. Fu pressoché muto nelle poche occasioni di dialogo che affrontò, e in silenzio si sorbì un cazziatone da Guido Merli. Il quale gli vomitò addosso ogni bestemmia possibile e riattaccò urlandogli che se credeva d’essere improvvisamente diventato Beckenbauer si cercasse un altro procuratore. Di tifosi incontrò quasi nessuno. La sola eccezione fu Emiliano, incrociato il venerdì sera al parco Mariambini. Si trovarono loro due e Pippo. Emiliano gli diede una pacca sulla spalla chiedendogli se andasse tutto bene; Nedo fece ok col pollice e ricambiò la pacca, ma lo sguardo puntava troppo altrove perché fosse vero.
La domenica successiva Nedo non venne spedito in tribuna soltanto perché Bersani fu costretto a portarlo in panchina dalla squalifica di Vascotto. Prese ancora una volta posto nell’angolo di panchina più lontano dall’allenatore. Il Milan vinse 2-0 con una doppietta di Van Basten, che dall’inizio della partita ridicolizzò in modo sublime la coppia di centrali Bonazzi-Natali. I quali sommavano meno di 40 anni e soltanto 12 partite di serie A. L’olandese non ci mise cattiveria nel maltrattare i due, né sarebbe stato necessario. Segnò all’inizio di entrambi i tempi coi due soli tiri che scagliò in porta. Poi si calmò e chiese la sostituzione a metà ripresa. Un fuoriclasse sa quando è giusto fermarsi, specie nei confronti di un avversario palesemente inferiore. Soltanto Bersani poteva pensare che una coppia di centrali formata da un 22enne che sei mesi prima faceva la C1 e un 17enne alla terza partita da professionista potesse fermare un Van Basten. Nedo ricordò i duelli della stagione precedente, quando a San Siro il Milan schiantò l’Empoli 4-0 e a lui nemmeno riusciva di beccarlo sugli stinchi, Van Basten. Al ritorno fecero 0-0 perché i rossoneri erano alla vigilia di un impegno di Coppa dei Campioni e perché Furlan incartò la partita con un numero di marcature a uomo come non si vedeva dagli anni Settanta. Se giochi contro una squadra come quella, e hai la buona ventura di trovarla distratta, blocca ogni suo movimento e spera che quella smetta presto di pensare alla partita di oggi. Così fece Furlan, e incassò un punto che fece la differenza nella corsa alla salvezza. Invece iBersani se la giocò come sempre, alla pari: 11 giocatori in azzurro contro 11 in rossonero, qual era il problema? Dopo la gara il tecnico empolese dichiarò d’aver visto molto equilibrio in campo e che i suoi avevano tenuto il confronto con grande applicazione. Sacchi ribadì le stesse cose a proposito dell’Empoli, aggiungendo che gli era parsa una squadra ricca di valori e cultura.
Arrivò così una nuova pausa del campionato, per fare spazio a due amichevoli della nazionale: contro l’Algeria a Vicenza sabato 11 novembre e a Wembley contro l’Inghilterra mercoledì 15. Da una sosta all’altra la classifica dell’Empoli era precipitata. In tre partite aveva colto soltanto 1 punto su 6 e era scivolato al penultimo posto, con soltanto il Verona alle spalle. Ma non era la classifica a suscitare le preoccupazioni maggiori. La situazione del gruppo nel giro di un mese era peggiorata. L’episodio di Genova aveva lasciato il segno; e per quanto si fosse cercato di scaricare su Nedo le colpe, era impossibile far finta che l’intera squadra non l’avesse seguito. Il rapporto di fiducia fra tecnico e giocatori era assestato su un grado bassissimo, specie dopo le rivelazioni di Piras. Il gioco stentava a vedersi, e i risultati s’erano fatti deficitari. Se davvero un Progetto c’era, sarebbe stato bene si manifestasse alla svelta.
Non vennero concessi giorni di vacanza, stavolta. La squadra riprese gli allenamenti il martedì, come fosse una normale settimana di campionato, e il giovedì Nedo s’infortunò. Aveva appena scorto Lapo Gori sui gradoni e gli fece un cenno per dirgli di vedersi dopo l’allenamento. Poi si mise a darci dentro nella partitella a ranghi misti. Per la ripresa del campionato era fissata la gara contro la Fiorentina al Comunale, e non sarebbe stato lui a dare a Bersani il pretesto di escluderlo dalla lista dei 16. Mise una foga eccessiva per raggiungere un pallone a mezza altezza, che forse mai sarebbe arrivato a Renzi. Il piede d’appoggio, il sinistro, rimase imprigionato in un’asperità del terreno e la caviglia fece un’anomala torsione verso l’esterno. Nedo sentì un “clack”, un rumore simile a quello delle dita fatte scricchiolare. Fu un dolore rapidissimo e fortissimo, che gli fece cacciare un urlo secco mentre perdeva l’equilibrio e rovinava sull’erba del campo sussidiario. Si rialzò immediatamente in piedi come spinto da una molla. Fu l’istinto di tastare quanto gravare fosse l’incidente: affrontare immediatamente la paura d’avere qualcosa di rotto, chiedere al corpo senza stare a ascoltare il dolore. Il corpo gli disse che la sua caviglia sinistra era uno straccio bagnato, forse non rotta ma debole abbastanza da piegarsi di torpore al contatto col terreno. Era già gonfia in modo preoccupante, e il fatto che la distorsione fosse in direzione interno-esterno la rendeva più grave. Sorretto da Bonazzi e Monaldo, Nedo rientrò negli spogliatoi dove il medico sociale Ghelli non poté far altro che portarlo in ospedale a fare delle lastre. Risultò che era una brutta distorsione, tale da richiedere l’ingessatura. E poiché il ghiaccio non aveva frenato il gonfiore di piede e caviglia si resero pure necessari tre giorni di pre-ingessatura, con l’applicazione di pomate. Roba da circa un mese e mezzo fra inattività, riabilitazione e recupero. Sarebbe stato disponibile nella seconda metà di dicembre, dopo la partita del 17 a Ascoli. Avrebbe sfruttato la sosta natalizia e sarebbe stato pronto per la partita in calendario l’ultimo dell’anno contro il Genoa. Sempre che tornare abile significasse avere possibilità d’essere arruolato.
Questo pensiero pessimista di Nedo si mescolava allo scambio di pareri fra Ghelli e l’ortopedico di turno all’ospedale San Giuseppe, mentre tutti e tre si avviavano all’uscita. Passando davanti al gabbiotto d’ingresso il loro sguardo si soffermò su quello dell’addetto alla portineria. Che era un omino tarchiato sui 45 anni, baffi e capelli nerissimi e una sigaretta che gli si stava consumando fra indice e medio con la lunga coda di cenere sospesa sul vuoto. Nemmeno s’accorse di loro e dello spettacolo che stava facendo di se stesso, con quella posa assorta davanti a un televisore da tre pollici a cristalli liquidi e le labbra appena dischiuse dallo stupore. Nedo, Ghelli e l’ortopedico rimasero lì per almeno un minuto senza dire nulla, nell’attesa che tanto rapimento partorisse qualcosa; e intanto non avevano l’animo di richiamare quello dallo stato di trance. Alla fine fu l’ortopedico a infrangere il cerchio del silenzio:
<Che succede, Panelli?>.
Quello ebbe un soprassalto, e forse in altri momenti si sarebbe anche scusato per quella fuga da fermo se non fosse stato per la straordinarietà di ciò che vedeva:
<E’ incredibile, dottore. Chi l’avrebbe mai detto?>.
<Ma cosa?> chiese Ghelli ansioso, mentre s’avvicinava al gabbiotto.
L’infermiere puntò lo sguardo verso il medico sociale dell’Empoli, come s’accorgesse soltanto in quel momento che altre due persone erano lì assieme all’ortopedico.
<Stanno tirando giù il Muro di Berlino. Proprio in questo momento>.
Girò il minuscolo televisore facendo in modo che vedessero anche loro. E in quattro, tutti in posizione sguincia, dovettero dividersi tre pollici di microschermo per assistere al passaggio della Storia: 0,75 pollici di cambio d’epoca pro capite. Fu un contagio. La catatonia che era stata di Panelli invase i corpi degli altri tre. Li inchiodò a seguire quell’evento che stava cambiando il mondo e a vederlo sciolto in una composizione di colori acidi, una sequenza d’immagini nitide o sbavate a seconda della posizione che ciascuno di loro guadagnava rubando un centimetro all’altro. L’audio era disturbato dai continui movimenti dell’apparecchio, appena percettibile pur alzando al massimo il volume e spostando l’antenna. Poi i disturbi alla trasmissione crebbero fino a scemare dentro una bassa tensione che come un buco nero inghiottiva frammenti di cemento, e calcinacci, e il commento gasato del cronista, convinto d’essere lui la Storia anziché raccontarla.
<Maremma ‘ane, aggeggio di merda!> sibilò Panelli, mollando una manata al vetro del gabbiotto.
<Che succede?> gli chiese l’ortopedico.
<Succede che questi televisorini d’i ccazzo mangiano le batterie come piranha. Una carica di Duracell ‘un fa più di du’ ore, puttanaccia zozza>.
<Ma non ha l’alimentatore?> fu la domanda speranzosa di Ghelli.
<E ‘un lo ritrovooo!> gli si rivolse imprecante Panelli, quasi che responsabile di quello smarrimento fosse il medico sociale dell’Empoli e perciò non si mettesse pure a fare domande idiote.
Con Nedo sdraiato per lungo sul sedile posteriore, Ghelli guidò distratto dalla ricerca di una stazione radio che desse informazioni su ciò che accadeva a Berlino. Quasi chiedeva a Nedo di scendere dall’auto e andare zoppo in farmacia a comprare la pomata e dei rotoli di garza, pur di non perdersi un secondo d’informazione. Lo scaricò sotto casa, gli chiese frettolosamente se avesse bisogno d’altro e sgommò via dicendogli che sarebbe tornato l’indomani con un paio di stampelle.
Il primo problema si presentò immediatamente: portare Pippo a spasso. Era dietro la porta a grattare e quando lo vide presentarsi saltellando su un piede l’espressione gli si rabbuiò. Comprese di doversi trattenere ancora un po’, nella migliore delle ipotesi. Nedo si abbandonò pesantemente sul divano del salotto, poggiò la caviglia destra gonfia su un cuscino e compose un numero di telefono. In un momento come quello, la Francy sarebbe stata ben lieta di mostrarsi indispensabile. E purtroppo, in un momento come quello, lui sapeva che lo era.
Lei fu lì nel giro di mezzora. Portò fuori Pippo, che quando la vedeva era sempre riottoso ma quella sera aveva atteso troppo per sottilizzare. Poi andò a prendere le pizze. Gli spalmò la pomata sulla caviglia con una lentezza ieratica. E già che c’era gli fece pure un pompino, senza che fosse chiaro chi dei due stesse facendo una cortesia all’altro. Se ne andò che era quasi mezzanotte, senza chiedere di rimanere e mettendosi a disposizione per l’indomani. Adesso che lui aveva bisogno davvero, poteva permettersi di recitare la parte di quella capace di non essere pressante e di dispensare sollecitudine in modo disinteressato. Stronza al cubo, pensò Nedo mentre sentiva scattare la porta alle spalle di lei. Stronza appena un briciolo più di lui, che almeno si trovava in stato di necessità.
La Francy fu da lui già l’indomani alle 7, per portare i bomboloni a Nedo e condurre Pippo a spasso, prima di entrare al lavoro nella Cooppona, la grande Coop di via della Repubblica dove da 5 anni faceva la cassiera. Se ne andò dicendo che, se a lui stava bene, sarebbe passata anche la sera verso le 8. Certo che gli stava bene. Che alternativa c’era? Andò avanti così venerdì e sabato mattina. Da casa sua passarono Assirelli, poi Buzzi&Chiorazzo. Nel tardo pomeriggio di venerdì si fecero vedere Flaviano De Luca e Matteo Rinaldi. Uscendo incrociarono Carla. Che rimase dieci minuti e proprio non volle togliere di dosso il giaccone. Era stranamente impacciata. Non metteva piede in quella casa da quasi tre mesi e l’accoglienza festosa di Pippo acuì l’imbarazzo. Chiese a Nedo dell’infortunio, accettò un cioccolatino – ma niente bibite o caffè – e nel breve tempo che rimase lì dentro sbirciò tre volte l’orologio. Il medico sociale Ghelli passò le mattine di venerdì e sabato. Fu lui, assieme a Flaviano De Luca, a accompagnare Nedo dai suoi a Montelupo, nella tarda mattinata di sabato. Flaviano guidò l’auto di Nedo con Pippo sul retro. Ghelli sarebbe passato il lunedì mattina alle 8, per portare Nedo dall’ortopedico di fiducia della società per l’ingessatura.
Per la seconda volta nel giro di pochi mesi, dopo i giorni della pausa di Ferragosto, Nedo si ritrovò a dormire nella sua camera come prima di andare via da casa. Pensò che staccare per qualche giorno dall’ambiente empolese gli facesse bene. Trascorse lì la sera del sabato e la giornata di domenica. Si mosse per casa reggendosi sulle stampelle, e di tanto in tanto andava di là a vedere qualcosa in tv. Assistette alla stentata vittoria dell’Italia contro l’Algeria, con gol di Aldo Serena segnato in fuorigioco. Fu una nazionale mediocre, che peggiorava con l’avvicinarsi dei Mondiali. Anche guardarla in tv stava diventando una noia insopportabile. Ma non a questo pensò Nedo, mentre seguiva la gara e il commento di Bruno Pizzul. Pensò a Diego Favrin e Marta, che poche ore prima si erano sposati a Bassano del Grappa, a poche decine di chilometri da dove la partita fra Italia e Algeria si stava giocando. Nedo non dubitò che Diego avesse proposto alla sua fresca sposa di rinviare il banchetto di nozze alla sera, per fare in tempo a essere al Menti e veder giocare la nazionale. Di questa e altre pensate era capace quello spostato. Buon per lui, aver trovato una donna che oltre a essere una gnocca galattica aveva il pregio di ricondurlo sempre coi piedi per terra.
Poco a poco Nedo si lasciò andare dentro una corrente di pensieri che presero a mescolarsi senza un ordine. Pensieri che contenevano altri pensieri che aprivano botole su pensieri sottostanti che proiettavano luce su pensieri nascosti che svelavano i lati oscuri di tutti quei pensieri che parevano limpidi. Bel oltre le cinque del pomeriggio si scosse ritrovandosi davanti a un teleschermo sul quale passava un programma per ragazzi. Pigiò il tasto rosso del telecomando, ma non gli parve che il silenzio fosse molto più profondo di qualche attimo prima. La casa era avvolta nel buio di un pomeriggio di metà novembre e nell’immobilità lasciata dall’assenza di babbo Antonio e mamma Erminia. Pippo ronfava di là, nella camera di Nedo.
Quello sprofondo di solitudine mise Nedo a disagio. Una sensazione di smarrimento gli fu subito dentro come fosse lì in agguato, pronta a prenderlo in un momento di fragilità. Era la casa in cui era cresciuto, era la cittadina in cui era nato, era un pomeriggio di novembre in cui faceva buio presto come a centinaia ne aveva attraversati, e lui era solo come quasi sempre. Eppure d’improvviso tutto quello gl’instillava pesantezza. Si alzò sul piede buono e saltellò verso l’interruttore. La violenza con cui la luce artificiale si rovesciò sulla cucina gli provocò una sensazione più fastidiosa di quella che aveva cercato di scacciare. No, non bastava girare un interruttore e far dissolvere il buio. Reggendosi sulla gamba destra cominciò a girare smarrito per il piccolo ingresso. Lì la penombra era ancora più cieca ma Nedo nemmeno ci pensò a girare l’interruttore. Tenendosi poggiato alla parete barcollò fino in salotto, illuminato dalla luce esterna dei lampioni, e s’abbandonò sul divano.
Sulla poltrona di fianco la prima pagina dell’Unità titolava ancora sul crollo del Muro e sui rivolgimenti in Europa orientale. Nedo aveva dato un’occhiata al giornale subito dopo pranzo, nell’attesa che iniziasse la partita della nazionale. Lo riprese fra le mani senza sapere cosa farne, lo sfogliò nel buio riuscendo a malapena a leggere i titoli d’apertura che già conosceva, lo ripose ripiegato al contrario come l’avesse letto da cima a fondo. Sentì che il peso di quella solitudine lo stava soffocando. Non era quella casa, e non era quel pomeriggio. Era tutto insieme, in quel momento che sentirsi solo gli mise paura per la prima volta in vita sua.
Riprese a saltellare per quei 60 metri quadri di casa, e più faceva avanti e indietro più aveva l’impressione che quelle mura gli si restringessero intorno, e intanto Pippo continuava a ronfare senza sentire la pesantezza di quel piede che ricadeva per terra a ogni passo. Non doveva uscire di casa né era consigliabile per la fatica che gli sarebbe costato. Ma quando le 6 stavano per scoccare sull’orologio in ceramica della cucina gli parve fosse l’unica cosa da fare per spezzare l’assedio di quello stato d’animo. Indossò frettolosamente il giaccone, afferrò le stampelle e si chiuse la porta alle spalle nel giro di una manciata di secondi.
Il freddo era sopportabile. A Nedo toccò fermarsi ripetutamente con qualcuno che gli chiedeva cosa fosse successo al suo piede sinistro. Sulla spianata in mezzo al corso Garibaldi stavano per iniziare i lavori di costruzione di un monumento alla tradizione fluviale di Montelupo: una barca, progettata secondo uno stile che l’amministrazione comunale preannunciava originale. Sarebbe stata rifatta anche la pavimentazione dell’intero corso. Qualcuno, avendo visto il progetto, sosteneva fosse una schifezza. Chissà. Intanto tutto era pronto per lo scavo, e per qualche tempo quei cinquanta metri in cui si concentrava lo struscio montelupino si sarebbero trasformati in un cantiere.
In fondo al corso Nedo riconobbe la sagoma di Eleonora. Era ferma nella piazzetta. Dava le spalle alla caserma dei Carabinieri e discuteva con un’anziana signora appena uscita dalla bottega del macellaio. Con loro era un uomo che pareva qualche anno più grande di lei – e di Nedo – alto e brizzolato, curato nel baffo e nell’abbigliamento, una sciarpa di seta che usciva dal cappotto scuro.
Nedo rimase immobile a guardare il trio – a guardare lei, Eleonora. Che esibiva il sorriso garbato di sempre. Quello che a lui aveva smesso di mostrare in un pomeriggio di maggio del 1977. Indossava un lungo cappotto di cammello e guanti di pelle nera, teneva una mano stretta alla cinghia della borsa anch’essa in pelle nera. Lo vide, e ebbe un attimo di smarrimento. Si fissarono, e l’incantamento di loro due fu lo stesso dell’uomo che era con lei, e della signora con le braccia allungate dalle buste della spesa. Chiunque passasse avrebbe notato che ciascuno dei due stesse guardando proprio l’altro; impossibile non notare quell’uomo alto in stampelle, impossibile non notare che lo sguardo di lui fosse calamitato da quella donna laggiù – e da chi altri sennò?, dalla vecchina con la spesa?, o dal pesce lesso in abiti griffati? – e che lei stesse ricambiando.
Furono secondi eterni, dai quali lei si riebbe salutando frettolosamente la vecchina e mostrandole i cocci del sorriso che le aveva rivolto qualche istante prima. Poi prese a braccetto l’uomo mentre quello le chiedeva conto di qualcosa, e lo diresse su un lato della piazza. I due sparirono dalla parte di via Giro delle Mura anziché percorrere a ritroso corso Garibaldi venendo incontro a Nedo. Che rimase lì ancora un po’, finché non si sentì picchiettare sulla spalla. Era Michele, uno degli amici che frequentava quando si fermava qualche ora a Montelupo. Sedettero a prendere un caffè al bar più vicino, e parlarono dell’infortunio e dell’Empoli mentre Nedo continuava a ripassare nella mente quello sguardo di Eleonora. Era trascorso tanto tempo, forse non c’era più l’astio che per una decina di anni lei gli aveva esibito come uno scudo ogni volta che i loro occhi s’incrociavano. E a ogni occasione lui aveva provato lo stesso disagio, nonostante gli anni trascorsi e il fatto che entrambi fossero cresciuti da quella volta in cui lei aveva vomitato l’anima giù verso il fiume Pesa e poi era scappata in lacrime maledicendolo con una rabbia da incenerirlo.
Nedo pensò per tutta la serata a quello sguardo di Eleonora che finalmente aveva smesso l’ostilità, e stette a chiedersi se non fosse stata soltanto una sua impressione. Chiese di lei a Michele e seppe che Eleonora si era laureata in lettere e insegnava in una scuola media, da qualche parte nel circondario; il tizio assieme a lei era un ricco cenciaio pratese, stavano assieme da un paio di anni. Con quelle scarne informazioni, Nedo se ne tornò a casa che erano quasi le 8, e imboccata piazza VIII agosto 1944 incontrò babbo Antonio. In silenzio percorsero i pochi metri fino al portone, e una volta entrati si sistemarono in cucina davanti al televisore. Pareva a Nedo che babbo Antonio fosse in quel periodo più pensieroso che mai. Certi momenti era evidente che il suo mutismo non fosse distanza ma assenza. Dov’era in quei giorni? Aveva sempre saputo parlare senza dire, ma da qualche settimana non parlava più nemmeno a quella muta maniera. Stava avvenendo giusto nel momento in cui Nedo sentiva una necessità di parlare con suo padre che mai aveva avvertito. Parlare di quel suo momento di carriera più difficile che mai; del rinnovo contrattuale con l’Empoli che forse non sarebbe arrivato più; di Bersani, e di marcatura a uomo e a zona, di tutte quelle cose del calcio che babbo Antonio s’era sempre rifiutato di capire ma chissà perché in quel momento, credeva Nedo, sarebbe stato pronto a ascoltare. E di Ned Ludd; sì che gli sarebbe piaciuto parlare con babbo Antonio di Ned Ludd e di luddismo. Quanto lo avrebbe apprezzato! E quanto lui avrebbe voluto sentirsi apprezzato, e fargli capire che fra i loro mestieri non c’erano tutte queste differenze, che i destini nelle condizioni di lavoro potevano essere molto simili, e non era una questione di mestieri più o meno seri.
Ebbe intenzione di dirgli tutto questo. Però vide babbo Antonio sistemarsi sulla sedia e accendere il televisore per seguire il telegiornale. E poi si sentì anche stanco. La passeggiata lo aveva provato, e la tensione che l’aveva preceduta gli s’era depositata addosso come ruggine assieme all’emozione suscitata dallo sguardo di Eleonora. Non era nelle migliori condizioni per affrontare il discorso con babbo Antonio. Bisognava avere a disposizione del tempo, e anche una lucidità diversa. Aveva da stare lì ancora un paio di giorni. Ci sarebbe stata occasione per parlare con babbo Antonio.
Si ritirò in camera che non erano ancora le 10, e alle 10 e mezza dormiva già d’un sonno pesante.
Si risvegliò dentro una domenica di sole. La trascorse quasi interamente in casa, affrontando un via vai di gente che ebbe una pausa soltanto durante l’orario di pranzo. Passarono Ghelli e Assirelli intorno alle 11, e subito dopo fu il turno di Flaviano De Luca e Massimo Vascotto. Nel primo pomeriggio fece una puntata la Francy, che chissà come si era procurata l’indirizzo dei genitori di Nedo e venne a fare un salutino veloce, come una persona che ci tenga a dimostrare di non essere invadente. Intorno alle 18 passarono Magno e Berti, e sull’uscio trovarono la zia Gina. Era la sorella di mamma Erminia e viveva a Montespertoli, vedova da tre anni dello zio Egidio. Nessuno di loro incrociò babbo Antonio, che quel giorno rimase fuori di casa più del solito.
Come già era accaduto in occasione della precedente sosta del campionato, quella sera di domenica babbo Antonio tardò sull’orario di cena. Stavolta non l’aspettarono. Tornò che erano quasi le 10 e mezza e entrò in casa col passo di un automa. Nedo s’apprestava a andare a letto, ma vedendo il babbo in quello stato s’arrestò. Lo seguì mentre sedeva su un lato lungo del tavolo e faceva cenno di no con la mano a mamma Erminia che gli chiese se volesse scaldate le lasagne avanzate a pranzo. Anche lei lo guardò ansiosa mentre gli vedeva impugnare con decisione il telecomando e accendere il televisore su Rai Tre. Una coda di pubblicità lasciò spazio al notiziario, che lo speaker aprì annunciando la notizia del giorno: durante un’assemblea tenuta poche ore prima alla Bolognina il segretario del PCI, Achille Occhetto, aveva annunciato che il partito avrebbe cambiato nome cancellando l’aggettivo Comunista. Sentendo quella notizia mamma Erminia smise di guardare il marito. Nedo ebbe impressione che le ginocchia le cedessero, mentre s’aggrappava alla spalliera della sedia sulla quale s’accomodò. E lui seduto dietro loro, con la gamba distesa su una seggiola in vimini, che sentiva lo shock doppio; per quel cambiamento e per l’effetto provocato sui genitori.
Aveva sempre votato PCI. Mai avrebbe creduto che la croce messa sul simbolo falce e martello pochi mesi prima, alle Europee di giugno, potesse essere l’ultima. Ma in quel momento la cosa che più lo preoccupò fu l’annichilimento che vide abbattersi sui volti e sui corpi dei genitori. Erano catatonici, per lunghi attimi parve a Nedo che nemmeno respirassero mentre il cronista della tv metteva in relazione l’annuncio di Occhetto col crollo del Muro di Berlino. Poi passò un servizio che riferiva dello sconquasso in corso nei paesi dell’Est Europa, e quando fu il momento della politica interna giunse un segnale di vita da mamma Erminia. Si alzò e si ritirò in camera da letto con espressione assente. Un attimo dopo babbo Antonio spense il televisore e rimase con lo sguardo puntato lì, sul teleschermo buio.Passarono i minuti, e i quarti d’ora, e a mezzanotte inoltrata babbo Antonio era ancora lì seduto con lo sguardo fisso sul teleschermo. E Nedo alle sue spalle, con lo sguardo fisso su di lui. Gli pareva di sentire il rumore dei pensieri di suo padre, e era lo stesso rumore che negli ultimi mesi doveva essere stato dentro la testa sua.
Quello era il momento di dire. Sentì che doveva alzarsi e accomodarsi di fronte a babbo Antonio. E parlare. Di quanto quel momento fosse simile per entrambi. Stava succedendo loro la stessa cosa, qualcuno aveva deciso di prendergli l’identità e la dignità, e buttarli nella spazzatura. E loro, cosa avevano fatto di male? Fino a ieri erano nel giusto, facevano ciò che avevano loro insegnato, e che con scrupolo e coscienza avevano imparato a fare. Avevano creduto in quello che facevano; e poiché quello che facevano era quello che erano, avevano fortemente creduto in se stessi.
Lui, stopper, aveva imparato l’arte di braccare l’avversario per tutto il campo sfidandolo in un duello fra uomini e facendolo con l’abnegazione e lo spirito di sacrificio che nobilitavano l’ingratitudine del mestiere. Così gli avevano insegnato, e lui imparando aveva creduto, e credendo in ciò che aveva imparato aveva creduto in se stesso. Il babbo, comunista, aveva imparato da suo padre Achille, partigiano, l’ideale di una società più giusta e egualitaria e il valore della democrazia come fatto di discussione e di partecipazione. Questo aveva respirato e imparato fin da piccolo, e imparandolo ci aveva creduto, e credendo aveva creduto in se stesso e nella sua militanza, fortificandosi nelle sconfitte politiche e ingoiando i compromessi politicanti.
Poi da un giorno all’altro qualcuno era venuto da Nedo e gli aveva detto, tu, sì tu, non servi più, quello che sei, quello che sei sempre stato, quello che contavi di essere sempre non va più bene, e non venirmi a dire che non hai fatto nulla di sbagliato, che sei ancora integro fisicamente, che non hai avuto scadimenti tecnici e atletici, ti abbiamo detto che non servi, sei inadatto, sta passando la modernità e tu rimarrai fuori dalla giostra, e non provare nemmeno a salirci perché quelli come te non sanno nemmeno cosa sia la giostra della modernità, non serve più quello che tu sai fare, e non servi più tu, che sei quello che sai fare. E poi giusto quella sera venne qualcuno da babbo Antonio e gli disse, tu, sì tu, quello in cui hai creduto per una vita è da cancellare, e non serve che tu dica che pareva tutto giusto, perché non conta che una cosa sia giusta per essere anche utile, e non serve tu ci dica che ci hai creduto con tutto te stesso, perché tutto te stesso è niente rispetto all’opportunità, e quest’opportunità dice che il nome non va più bene, ma poi, scusa, cosa mai sono i nomi?, dettagli, e non insistere sul fatto che i nomi sono le cose, e le persone, e le storie di tante persone unite in un ideale, sta passando il treno della Storia, e allora pensa a prenderlo senza farti scrupolo di come ti chiami e senza pensare che come ti chiami è anche come sei, perché il treno della Storia è adesso, e se ti fermi a pensare se prenderlo l’hai già perso, e dato che l’hai già perso meritavi di perderlo, e allora di quelli come te non sappiamo cosa farcene, restatene pure lì, comunista a vita e inadatto.
Sì che era il momento di parlargli. Ma cominciando da dove? Dalla differenza fra zona e uomo? Dall’organizzazione collettiva del lavoro calcistico come principio di deumanizzazione? E come spiegare a lui, comunista da una vita, che nel calcio il collettivismo stava ammazzando l’individualismo? Se davvero babbo Antonio fosse stato a ascoltarlo gli avrebbe detto che era cosa buona e giusta, e che l’individualismo sregolato è un male, nel calcio come ovunque. Ma poi, quando mai babbo Antonio aveva voluto sentir parlare di calcio? E come era possibile pensare che potesse farlo giusto in quel momento che gli stavano togliendo il nome e forse il partito? Sì, va’ a farglielo capire che ci sono analogie. Va’ a farglielo capire adesso, mentre una rabbia inespressa gli provoca un tremore contenuto a stento, e sulle gote scende qualcosa di simile a lacrime. Cosa vuoi che ti stia a sentire se gli parli di calcio, e intanto lui si vede svanire gli ideali di una vita e se stesso come individuo capace di alimentare ideali? E magari prova anche a raccontargli la storia di Ned Ludd, e del luddismo. Così la prenderà come una burla e rovescerà su di te tutta la rabbia. Provaci, e vedrai per la prima volta unira sconosciuta esplodere nel babbo, mentre urlando ti chiederà cosa c’entri quel dramma per milioni di compagni e compagne con un’idiota storia di pallone.
Non aveva mai parlato a cuore aperto con suo padre, Nedo. E non lo avrebbe fatto mai più.
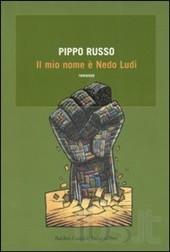
Lascia un commento